Socrate e il Timeo di Platone: i solidi platonici e gli elementi |
| Storia dell'astrologia | |||||||||||||||||||||||||||
|
Platone, nato ad Atene il 428 a.C., è stato il suo allievo più famoso e, a sua volta, il maestro di Aristotele. Insieme, hanno posto le basi del pensiero filosofico occidentale. L'opera è basilare per l'astrologia. In essa troviamo per la prima volta la descrizione dettagliata di come gli elementi (Fuoco, Terra, Aria ed Acqua) appaiono in natura, la loro forma geometrica e come essa condiziona il modo in cui gli elementi si comportano e si relazionano tra loro. La tesi secondo la quale la materia è composta dagli elementi, fu messa in ombra dalla teoria atomistica (secondo cui gli atomi sarebbero immutabili) di Democrito. Oggi però, sappiamo, grazie alla scienza, che anche l'atomo è divisibile in parti più piccole e persino gli elettroni sono divisibili in particelle ancora più piccole, al punto che, persino gli scienziati, ammettono di non essere ancora riusciti a trovare la particella più piccola. La teoria degli elementi e delle loro basi geometriche, che, secondo la testimonianza di Proclo, ha ispirato anche il lavoro del matematico Euclide, resta quindi ancora oggi attuale e valida. I quattro elementi, che per l'astrologia hanno una fondamentale importanza, non sono però il fondamento ultimo della materia, ma sono a loro volta composti da qualcosa di più basilare: dei solidi così piccoli da risultare invisibili, ma che, se riuniti in grande quantità, appaiono come, appunto, i quattro elementi. Questi solidi dotati di particolari proporzioni sono anche detti "solidi platonici". Platone, nel Timeo, associò ad ognuno di essi un elemento: al tetraedro fu associato il Fuoco, al cubo la Terra, all'ottaedro l'Aria, all'icosaedro l'Acqua. Queste figure geometriche (poliedri regolari), proprio per la loro straordinaria regolarità, furono studiate e ammirate, già prima di Platone e Socrate, da Pitagora. Infatti, la perfezione data dalla loro "regolarità" è sinonimo di conoscenza. Dato un lato o un angolo, grazie alle proprietà ed alle loro proporzioni intrinseche a questi solidi, possiamo conoscere tutto il resto.
Per Platone gli elementi erano composti da due specie di triangoli rettangoli, uno che era la metà di un quadrato, l’altro che era la metà di un triangolo equilatero. Egli pensava che i quattro elementi di Empedocle (Fuoco, Aria, Acqua e Terra), non indicavano la materia, ma piuttosto un modo di essere della materia. Originariamente tutto il modo materiale era mescolato e “i vari elementi stavano in luoghi diversi prima che fossero sistemati in modo da formare l’universo” [1]. Poi Dio li fornì di forma e di numero, e “li fece il più possibile belli e buoni, traendoli da cose che belle e buone non erano”. Le due specie di triangoli indicati erano le forme più belle e quindi Dio le usò per costruire la materia. Per mezzo di questi due triangoli era possibile costruire quattro dei cinque solidi regolari. La forma della terra erana cubica; del fuoco, un tetraedro; dell’aria, ottaedro; dell’acqua icosaedro. Quanto al dodecaedro, il quinto elemento, Platone diceva solo: “C’era tuttavia una quinta combinazione che Dio usò nel disegnare l’universo” [2]. Il Timeo di PlatoneDi seguito, trascriviamo alcuni brani estratti dal Timeo di Platone, dove vengono descritti gli elementi [3]. "Iddio, pose Acqua e Aria in mezzo a Fuoco e Terra, e li proporzionò fra loro il più possibile; in modo che il Fuoco fosse rivolto verso l'aria, l'Aria fosse rivolta verso l'Acqua e l'Acqua fosse rivolta verso la Terra. Infine collegò la Terra al Fuoco e compose un corpo visibile e palpabile." Conformemente alla fisica aristotelica ed al pensiero di Aristotele sugli elementi, il Fuoco (elemento più leggero e meno corporeo e consistente) è contrapposto alla Terra (elemento pesante e composto da molta materia). Tra Fuoco e Terra (due estremi, in quanto il Fuoco è il più leggero, mentre la Terra è il più pesante), ritroviamo, Aria e Acqua, che hanno una qualità comune a Fuoco e Terra ed una qualità contraria: la Terra ha in comune con l'Acqua il freddo, mentre il Fuoco ha in comune con l'Aria l'umido. In ogni caso, emerge che, anche nel pensiero di Platone, tutti i corpi sono composti da un insieme di elementi distribuiti secondo opportune proporzioni. Il quinto elementoAi quattro elementi, associati ai quattro solidi platonici, si affianca un ultimo solido platonico (Dodecaedro) di 12 facce [4]. "Iddio compose tutto il mondo di Fuoco e Acqua e Aria e Terra, perché il mondo fosse, quanto poteva, animale perfetto, e di perfette parti". Timeo di Platone (verso 55). Se nel Timeo possiamo leggere di una figura a dodici facce usata dal creatore per il “tutto”, non è l'unico caso in cui il celebre filosofo ci parla di un quinto elemento che li contiene tutti e che "è a forma di animale". Questa figura a dodici facce a forma di animale, che ricorda da vicino lo Zodiaco ed i suoi 12 segni, viene, infatti, riproposta da Platone nella sua opera "La Repubblica" (verso 589) dove egli presenta “l’immagine simbolica dell’Anima” come un animale dalle innumerevoli teste, alcune mansuete ed altre feroci [5]. I quattro solidi, iniziando dalla prima specie, la cui composizione è piú semplice:
Tetraedro
Il primo solido, il Tetraedro, che rappresenta l'elemento Fuoco, ha la composizione più semplice e si compone di quattro triangoli equilateri: grazie alle sue proprietà una sfera può essere divisa in parti uguali. Ottaedro
La seconda specie (secondo solido, l'ottaedro che rappresenta l'Aria) è composta dagli stessi elementari triangoli (del Fuoco) legati insieme in otto triangoli equilateri, in modo che da ogni accostamento di quattro angoli piani si compie un solo angolo solido. Icosaedro
Il terzo corpo (terzo solido, l'Icosaedro, che rappresenta l'elemento Acqua), il quale ha venti facce triangolari e equilatere, si genera dai triangoli elementari, uniti cosí fra loro, in modo che facciano dodici angoli solidi (e 30 spigoli), ciascuno dei quali è compreso da cinque triangoli piani di uguali lati. Cubo
Il triangolo dai due lati uguali genera il quarto solido (il cubo, che rappresenta l'elemento Terra): ripetendo sé quattro volte, i suoi angoli diritti puntano verso il centro come un tetragono equilatero; e, uniti poi insieme sei di tali tetragoni, fatti di otto angoli solidi, ciascuno dei quali è composto da tre angoli piani e diritti: e cosí è nata una quarta figura di solido, che è il cubo, il quale ha sei piani e basi equilatere.
Innanzi tutto, che Fuoco, Terra, Aria e Acqua siano corpi, ciò è manifesto ad ogni uomo. E ogni specie di corpo ha profondità; e ogni profondità poi deve avere il piano e un piano è fatto di triangoli. Questi triangoli, tra cui quello bellissimo, li poniamo quali principi del Fuoco e degli altri corpi. La verità è che dai triangoli da noi scelti nascono le quattro specie di corpi. Platone e i cinque elementiDistinguiamo in Fuoco, Terra, Acqua e Aria. Alla Terra noi assegniamo figura cubica, perché è la piú immobile delle quattro specie di corpi e la piú consistente; e dimostrazione massima che quel solido è immobile, è data dalle sue basi sicurissime. Ora, dei triangoli prima citati, la base di quelli a due lati uguali è naturalmente piú sicura della base di quelli che hanno tutti i loro lati disuguali (la base sta più ferma). Assegnamo quindi la figura cubica alla Terra, e all'Acqua quella meno mobile, e quella mobilissima al Fuoco, e quella che è nel mezzo all'Aria; e al Fuoco quella acutissima, la seconda in acume all'aria; e la terza all'acqua e la quarta alla Terra. Infatti, quella di tutte queste figure che ha pochissima base (il tetragono, cioè il fuoco), è di necessità mobilissima, taglientissima e più acuta delle altre; ed è anche leggerissima, perché è composta da pochissime parti identiche. E' da considerare che tutte queste figure sono talmente piccole che noi, delle singole parti di ciascun genere, non vediamo niente a causa della loro piccolezza, e che solo quando si radunano molte insieme, allora si vede il loro volume. Ed è da considerare, inoltre, che Iddio, provvedendo con amore, fece proporzionatamente ogni cosa. Le relazioni tra gli elementiSe la Terra si "scontra" con il Fuoco, viene scomposta in piccole parti dall'acume (dalla forma appuntita) del Fuoco, qua e là rigirandosi, finché le sue parti, o sono cosí sciolte da trovarsi all'interno dello stesso Fuoco (che nutrono come la legna fa ardere il Fuoco), o si disperdono entro ad Aria o Acqua, o, disponendosi fra loro nuovamente, tornano Terra; perché non trapasserebbero mai in altra specie. Acqua spartita da Fuoco o anche da Aria, acconsente, ricomponendosi insieme, a fare un solido di Fuoco o due solidi di Aria; e se è divisa da Aria, si fanno di una parte sua due corpi di Fuoco. E nuovamente, se il Fuoco viene chiuso da Aria o da Acqua o da alcuna parte di Terra, essendo esso poco dentro a molti, dimenandosi in mezzo agli altri elementi, o é vinto e spezzato: e allora due corpi di Fuoco si ricompongono in uno di Aria. E se l'Aria è domata e sminuzzata, due interi corpi e mezzo di quella si costringono in uno di Acqua. Tuttavia, quando un genere si scontra con un genere diverso, ed è più debole e combatte con uno forte, tende a scomporsi in piccoli frammenti (sminuzzarsi in piccole parti). Per il contrario, quando corpi piccoli e pochi son chiusi fra molti piú grossi, essendo sminuzzati, si dissipano: ma quando si vogliono ricomporre nella forma del vincitore, il loro dissipamento ha fine: e cosí dal Fuoco nasce Aria, e dall'aria, Acqua. Infine, se un genere di corpi incontra un altro qualsiasi e combattano alla pari, non gli resta che sciogliersi tutt'e due, sino a che, respingendosi e sciogliendosi pienamente, non si rifuggano; oppure che i vinti, da molti facendosi uno e simile al vincitore, non rimangano a coabitare in quella forma. E per questi motivi, i corpi mutano cosí le loro forme: perché le moltitudini dei corpi di un genere si ritraggono verso il loro luogo proprio; ma resi dissimili tra loro, e per contrario simili ad altri corpi di diverso genere, per questo scuotimento sono portati al luogo di quelli, ai quali sono simili. I triangoli, mischiati fra loro, formano una varietà infinita, che deve interessare tutti coloro che vogliono ragionar della natura secondo verisimiglianza. Quanto a moto e a quiete, ora aggiungiamo che è impossibile che ci sia cosa mossa senza alcuno che la muove, o un "muovere" senza alcuna cosa mossa. E poiché, non essendo uguali quelli in movimento (perché si mescolano) segue che la quiete è nell'essere uguale, e il movimento è nella disuguaglianza. Dopo che il cielo ebbe abbracciato tutti i generi, essendo circolare e naturalmente voglioso di raccogliersi in sè stesso, se li strinse e non lasciò rimanere alcuno spazio vuoto. Onde il Fuoco attraversa tutto velocemente; l'Aria è seconda in velocità, in quanto è seconda in sottigliezza; e cosí gli altri. I corpi sono sempre portati su e giú ai loro luoghi di appartenenza finché ciascuno di essi muta in grandezza. E cosí perseverando in perpetuo la generazione della disuguaglianza, ella è motivo del perpetuo moto de' corpi; il quale è e sarà senza intermissione. Vari tipi di Fuoco, di Aria, di Terra e di Acqua. Detto ciò, si deve da considerare che ci sono molte specie di Fuoco, come la fiamma; e quello che si sparge dalla fiamma e non arde, ma sí porge come lume agli occhi; e quello che, morta la fiamma, rimane nei corpi infuocati (la brace). Allo stesso modo, c'è l'Aria limpidissima, chiamata etere, e quella torbidissima, chiamata nebbia e caliggine, e diverse altre specie senza nome, generate dalla disugualità dei triangoli. Per l'Acqua ci sono due specie principali: la umida, e quella che si scioglie. La umida, fatta di parti di Acqua piccole e disuguali, che è mutevole da sé, a cagione della disugualità della figura sua. L'Acqua fatta di parti grandi e uguali è piú stabile di umida, ed è ferma, ma se l'addentra il Fuoco e la scioglie, ella, perduta la sua egualità, prende piú del moto; e, fatta mobilissima, dalla prossima Aria è cacciata e distesa in Terra. Il distemperarsi della sua massa ebbe nome di struggimento, e di scorrimento lo stendersi che ella fa sulla Terra. E poi di nuovo sfuggendo il Fuoco, la vicina Aria, premuta da esso, premendo a sua volta la liquida e ancor leggermente mobile Acqua nelle sedi del Fuoco, la rimescola tutta; e quella, premuta, ripigliando la ugualità sua, essendo andato già via il fabbro della disugualità che è il Fuoco, riviene uniforme. Raffreddamento, è detto l'allontanarsi del Fuoco, mentre viene chiamato "serrato" quel corpo che si costringe dopo che il Fuoco ne è andato via. L'Acqua mista a Fuoco, quella sottile liquida, per il suo movimento ed il suo andare rivolgendosi verso la Terra, si dice fluida; e anche molle, perché le sue basi son cedevoli, siccome meno stabili di quelle della Terra. Quest'acqua, quando l'abbandonano Fuoco e Aria, divien piú uguale, e in sé medesima si raggruma per il loro allontanarsi. E se l'Acqua si serra molto fortemente, lontano dalla terra, si chiama gragnuola; Ghiaccio, se in Terra, neve se è di piú piccole parti e si serra, su, lontano da Terra; se in Terra, si chiama rugiada. Le moltissime specie di Acqua miste fra loro, stillanti per le piante provenienti dalla Terra, in genere, sono chiamate succhi. I quali, diversi essendo per loro diverse mischianze, hanno molte specie senza nome; ma quattro, di natura di fuoco, per essere molto parventi, ricevettero un nome. L'Acqua che contiene il fuoco e che riscalda anima e corpo, si chiamò vino. Quella polita, che è lucida e nitida, è l'olio: cioè pece, resina e l'olio medesimo e ogni altra cosa della stessa sostanza. Quella che spande mescolanze dentro a bocca e però porge dolcezza, universalmente, per questa sua virtú ebbe nome di miele. Quella che arde la carne e la dissolve, specie spumosa che è notabile fra gli altri succhi, si disse oppio. Quanto è alle specie di Terra, quella che distilla per Acqua, diviene cosí corpo petroso. L'Acqua mista a essa Terra, se picchiata è nella sua mischianza, trapassa in Aria; e, Aria fatta, ricorre su al suo luogo. Ma, non essendoci vuoto, ella preme l'Aria che è da presso; la quale, siccome più pesante, premuta e stesa attorno alla massa della Terra, costringe questa fortemente e la caccia dove si levò su l'Aria. E la Terra, premuta dall'Aria sí che scioglier non la possa Acqua, si fa pietra. Piú bella è quella trasparente, che ha parti uguali, lisce, di simile forma; la contraria è piú brutta. La Terra, se viene privata di ogni umore dal Fuoco sicché diviene piú secca, fa ciò che noi chiamiamo argilla. Alcuna volta la terra, rimanendole umore, strutta che è da Fuoco e poi raffreddata, diviene la pietra di color nero. E simigliantemente se ella è privata di molta Acqua, e ha parti piú sottili, ed è salata, condensandosi a mezzo sí che di nuovo la possa sciogliere Acqua, e se ne fa due cose: cioè nitro, il quale purga olio e Terra; e sale, il quale fa che le vivande s'insaporino. E si sono raddensati cosí poi tutt'i corpi di Acqua e Terra, i quali non si sciolgono per Acqua, ma per Fuoco. Fuoco e Aria non distruggono masse di Terra: poiché essendo le loro parti piú piccole, trapassano senza violenza per queste molte vie spaziose; e, non sciogliendo, la lasciano però soda. Ma le parti dell'acqua, da poi che naturalmente sono piú grandi, facendo violento passaggio e dissolvendo, la struggono. E cosí Terra, se ella non è serrata, solo l'Acqua la scioglie, e di viva forza. Se, invece, la Terra è serrata, nessuna cosa la scioglie salvo il Fuoco, perché a nessuna cosa è lasciato entrare, salvo che al Fuoco. L'Acqua, solo il Fuoco la scioglie, se la sua pressione è molto forte. Altrimenti, la scioglie anche l'Aria, spargendosi dentro le sue fessure. L'Aria compressa con grande forza, non viene divisa da nessuna cosa, salvo che tutti gli elementi insieme; se non è molto compressa, la scioglie solo il Fuoco. E dunque nei corpi misti di Terra e Acqua, finché l'Acqua occupa le fessure della Terra, le parti di Aria, non essendo lasciate entrare, scorrono al di fuori, e non riescono a dividerla. Ma il Fuoco, entrando con le sue piccolissime parti nei vani dell'acqua, e facendo esso all'Acqua ciò che l'Acqua fa alla Terra e ciò che lo stesso Fuoco fa all'Aria, fa in modo che il corpo misto (di terra e di acqua) si sciolga e torni scorrevole. Avviene che, tra i corpi, alcuni abbiano piú Terra che Acqua (tutte le specie di vetri e pietre, che si sciolgono); altri piú Acqua che Terra (tutti quei corpi condensati in forma di cera, e odorosi).
Note bibliografiche [1] "La chiave del mondo" di Giovanni Villani (Cap. 1.2) [2] V. nota 1. [3] I brani del Timeo di Platone riportati in corsivo sono tratti dalla versione del Timeo tradotta da Francesco Acri, a cura di Carlo Carena. La traduzione citata è stata riletta, semplificata e riadattata a cura di Dario Giugno. N.B. Al testo originale traduzione, sono stati apportati tagli, sono state inserite importanti modifiche (che seppur divergono dal testo originale e dalle scelte lessicali del traduttore, cercano di mantenerne inalterato il senso); alcune parti sono state riassunte e sono stati introdotti numerosi interventi esplicativi che non appartengono all'autore, ma che sono necessari per una lettura preliminare e per una più facile diffusione e comprensione del testo. [4] Il quinto solido platonico è il Dodecaedro, un poliedro di 12 facce, a base pentagonale. E' associato ad un quinto elemento chiamato "quintessenza" ed è associabile anche alla luce. [5] James Hillmann - "Conferenza magistrale" - in Linguaggio Astrale -ANNO XXXII n. 129, pag. 20 - Traduzione a cura di Margherita Fiorello Tags:
|
|||||||||||||||||||||||||||



 Socrate, vissuto ad Atene dal 470 a.C. al 399 a.C., è stato un filosofo, considerato da tutti il padre della filosofia. Celebre la sua affermazione "so di non sapere" che contiene i principi della filosofia e cioè l'amore per il sapere e la conoscenza.
Socrate, vissuto ad Atene dal 470 a.C. al 399 a.C., è stato un filosofo, considerato da tutti il padre della filosofia. Celebre la sua affermazione "so di non sapere" che contiene i principi della filosofia e cioè l'amore per il sapere e la conoscenza.






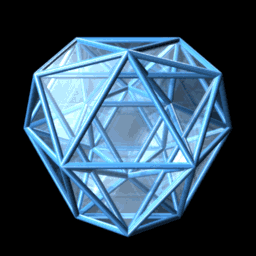





Commenti
RSS feed dei commenti di questo post.